Lun 7 Set 2009
Il terremoto aquilano e la tomba di Karl Heinrich Ulrichs
Posted by Antonio Picariello under arte/teatroNo Comments
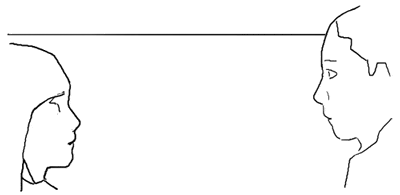
Il terremoto aquilano e la tomba di Karl Heinrich Ulrichs (Westerfeld 1825 – L’Aquila 1895)
Â
di Antonio Gabarrini *
Razzismo e omofobia sono le due brutte facce criminogene della stessa medaglia, come purtroppo avrebbero dovuto insegnarci gli inenarrabili stermini nazisti.
Ebbene, nell’italietta fascistoide, padana ed autarchica del sig. b., proprio in questi ultimi giorni l’emergenza democratica in cui versa il nostro Paese, ha messo a nudo – con le coltellate e le botte date a coppie di gay, l’incendio dei loro ritrovi e la probabile incriminazione per il reato di clandestinità dei 5 eritrei naufraghi sopravvissuti alla strage della settantina di compagni morti in mare – tutti i pericoli che stanno correndo i fondanti principi “libertari e di libertà †solennemente sanciti dalla nostra Costituzione repubblicana. In corso di progressiva demolizione a seguito del totale controllo dei mezzi d’informazione di massa e delle leggi ad personam autoemanate dal sig. b., della controriforma scolastica, dell’annunciata restrittiva regolamentazione delle intercettazioni telefoniche, della clericale stesura del biotestamento e via di questo passo.
Pur vivendo personalmente, insieme ad altri 70.000 miei concittadini un’altra terribile emergenza (quella del terremoto aquilano), ho sentito l’obbligo morale di ricordare una straordinaria figura pionieristica battutasi tenacemente ed a viso aperto, nella seconda metà dell’Ottocento, per il sacrosanto diritto della “libertà sessualeâ€: Karl Heinrich Ulrichs (Westerfeld 1825-L’Aquila 1895).
Il 28 di agosto è ricorso il suo 184° compleanno, da alcuni anni festeggiato dalla comunità gay nei pressi della sua tomba al cimitero monumentale dell’Aquila dove è sepolto. Al brindisi finale dell’irrituale cerimonia svoltasi il 30 u. s., – con una bandiera del Movimento adagiata sulla lapide, oltre ad una sua biografia (vedi oltre), una torta e due bottiglie di vino – ho partecipato anch’io insieme all’editore Roberto Massari, entrambi “eterosolidali†non solo nei confronti degli omosessuali qui convenuti, ma di “tutti e tutte†coloro che nel mondo subiscono vessazioni di ogni genere a causa delle loro opzioni sessuali.
Per Ulrichs, il destino ha voluto che dalla natia Germania approdasse, da esiliato e per ragioni di salute, nella città federiciana dove strinse amicizia con il marchese Niccolò Persichetti diventato presto suo protettore e mecenate.
Proprio al Persichetti dobbiamo le prime attendibili notizie biografiche di questo insigne giurista, scrittore, poeta, saggista, giornalista, latinista, amante della natura fino all’ossessione (nel 1889 si immerse per ben 71 giorni diversi nel fiume Aterno, l’ultimo dei quali a dicembre con l’acqua pressoché gelata), riservato e schivo come ogni anonimo viandante battente, senza meta, gli infiniti sentieri di una indomabile e indomita libertà .
Dall’orazione funebre tenuta dal marchese (poi data alle stampe), sappiamo che:«Carlo Arrigo Ulrichs fu di statura media, di fronte spaziosa, dalla quale spiovevano pochi ma alquanto lunghi capelli, di fisionomia seria e marcata da linee perfette, ornato di corta e rada barba, piuttosto secco e debole per bisogni e intellettuali fatiche, vestito d’indumenti forse più poveri che modesti, d’incedere calmo e grave senza affettazione, appoggiato ad un bastone, sempre in compagnia di qualche libro che stringeva sotto il braccio».
Nella puntuale biografia Karl Heinrichs Ulrichs. Pioneer of the Modern Gay Movemente scritta dall’americano Hubert Kennedy nel 2002, tradotta in italiano e pubblicata per la cura di Massimo Consoli (Massari Editore 2005), sono ripercorse tutte le tappe della sua formazione culturale, della sua innovativa teoria (per quei tempi) del «terzo sesso», dei suoi tentativi di far luce sul labirintico enigma dell’amore «maschio-maschile», dell’imprigionamento subito per le sue idee politiche, dei suoi scritti tesi all’affermazione di una riforma giuridica per l’abolizione della legge prussiana antiomosesuale, della fondazione della prima rivista omosessuale Uranus , e, infine del volontario esilio italiano (1880-1895) quasi tutto vissuto ad Aquila.
Dei suoi numerosi scritti dedicati alla causa degli urninghi o uranisti che dir si voglia (l’accezione etimologica è tratta dal Simposio di Platone, dove è la Venere Urania a proteggere gli amori omosessuali), vale la pena di ricordare i sei opuscoli pubblicati nel 1864-65 con lo pseudonimo di Numa Numantius sotto l’unificante titolo di Ricerche sull’enigma dell’amore tra maschi, nonché gli altrettanti usciti fino al 1879 con il vero nome dell’autore.
Ad Aquila (così si chiamava ancora la città ), oltre a scrivere una serie di racconti fantastici ed altri libri, vede la luce la rivista Alaudae (Le allodole) completamente in lingua latina, uscita (a partire dal maggio del 1889 fino al 1892 nei suoi 24 fascicoli) per i tipi del locale editore Perchiazzi e poi a Roma editata da  Ermanno Loescher, mediamente con otto pagine a numero, rivista consultabile (prima del terremoto: ci auguriamo non sia stata seppellita dalle macerie), alla Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi della città capoluogo.
Su questo importantissimo periodico diffuso da Ulrichs in tutto il mondo per favorire l’avvento di una lingua universale che fosse capace di ricomporre i confusi frammenti sparsi con la distruzione della Torre di Babele, ha pubblicato nel 1995 un esaustivo saggio il prof. Raffaele Colapietra sulla rivista trimestrale di studi demoetnoantropologici Lares (testo ignorato nella bibliografia kennedyana, ma consultabile su Internet).
Particolarmente significativo ci sembra, nei giorni di questa martoriata Perdonanza aquilana che stava sul punto di essere ridotta a cassa di risonanza delle strumentalizzazione mediatiche poste cinicamente in essere dal sig. b. per il suo riavvicinamento elettoralistico al Vaticano dopo le condanne delle gerarchie ecclesiastiche e di gran parte del mondo cattolico per gli arcinoti suoi stravizi sessuali, la descrizione della Festa del Perdono fatta in presa diretta da Ulrichs proprio in Alaudae.
Parafrasa e traduce in proposito dal latino il Colapietra:«Nel dies reliquiarum […] l’accalcarsi del popolo, il suono della tromba, l’accensione della candela sul torrione che affianca la facciata, la lettura della bolla d’indulgenza, di nuovo gli squilli, unus sacerdotum che dall’alto del torrione mostra le reliquie a destra e a sinistra, la moltitudine inginocchiata, l’horror sacro che pervade lo stesso Ulrichs, allorché, accanto al dito di S.Giovanni, è presentata la spina della corona di Cristo […]», mettendo così ben in evidenza le degenerazioni spettacolari nel frattempo intervenute, sostanzialmente ridimensionate nella sobria edizione di quest’anno, la cui matrice spirituale ha aleggiato lungo tutto il corteo costellato dalla spettrale scenografie delle macerie.
In attesa della venuta di giorni meno tetri di quelli attuali marchiati in negativo dal sisma, è perciò auspicabile una ristampa anastatica di Alaudae con relativa traduzione, se non altro per ridisegnare  ex post la straordinaria figura di questo aquilano “ad honoremâ€, a suo tempo già stimato, per le sue rivoluzionarie idee, dai giovani socialisti della città gravitanti attorno alla rivista “L’Avvenire della democraziaâ€.
A lui ed al Persichetti si deve, tra l’altro, il lancio di una sottoscrizione internazionale per l’erezione di un monumento dedicato a Sallustio (attualmente ubicato a Piazza Palazzo), realizzato poi dallo scultore fiorentino Cesare Zocchi, inaugurato però, per una serie contrattempi, solamente nel 1903, cioè ben 8 anni dopo la morte dell’intellettuale tedesco.
A distanza di oltre un secolo dalla scomparsa del Nostro, l’amministrazione civica un paio di anni fa gli ha dedicato l’intestazione di un piazzale nel Parco del Castello Cinquecentesco, saldando così in parte il debito d’onore contratto nei confronti di quest’antesignano dei combattenti per la conquista di basilari diritti civili. L’altra metà del pagamento del debito consiste nel dar finalmente seguito all’abortita interrogazione parlamentare del 2002 diretta all’allora Ministro dei Beni Culturali Urbani (a firma di Grillini, Vendola, Cialente, Lolli ed altri), con cui si sottolineava l’urgenza del restauro del sepolcro.
Il suo attuale più che precario stato, con l’iscrizione lapidea in latino pressoché illeggibile e l’incombente sprofondamento del tutto, impone un risolutorio intervento di consolidamento e restauro effettuabile in concomitanza dei prossimi lavori che interesseranno l’intero plesso monumentale, anch’esso messo a soqquadro dal devastante sisma che non ha guardato in faccia a niente e a nessuno.
Eppure, nonostante la desolante situazione in cui continua a versare l’intera città da ben cinque mesi, la nitida voce libertaria di Ulrichs circola ancora tra quelle ingrigite, paralizzate rovine: «Sono un sovversivo. Mi ribello contro la situazione esistente, perché ritengo sia una situazione d’ingiustizia. Combatto per la libertà dalla persecuzione e dagli insulti. Mi appello al riconoscimento dell’amore urningo. Mi appello a questo riconoscimento da parte dell’opinione pubblica e dello Stato».
Questo passo lo possiamo leggere in Invicta (1865). Da allora è trascorso quasi un secolo e mezzo.
Volare alto, per una città ed un territorio massacrati brutalmente dalla catastrofe del 6 aprile, significa rinsaldare, non solo simbolicamente, i legami storici e culturali con i suoi figli migliori, anche se adottivi, come tale deve  essere legittimamente considerato Karl Heinrich Ulrichs.
* Critico d’arte – Art Director del Centro Documentazione Artepoesia Contemporanea Angelus Novus, fondato nel 1988 (L’Aquila, Via Sassa 15, ZONA ROSSA). Attualmente “naufrago†sulla costa teramana. antonio.gasbarrini@gmail.com
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.